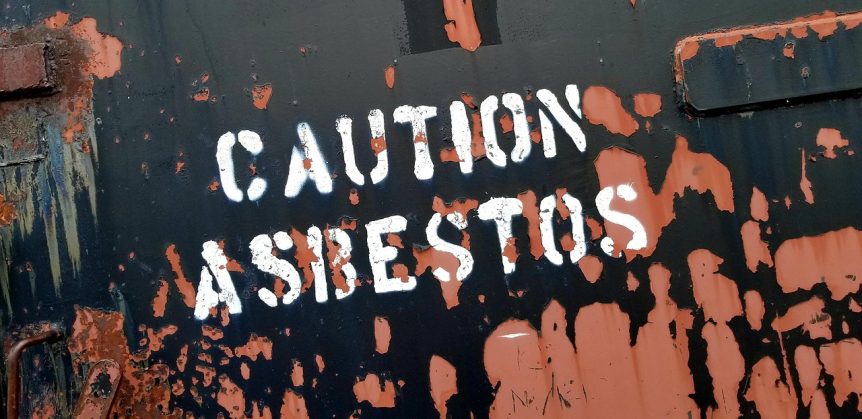a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Si è già parlato di prescrizione della richiesta di risarcimento del danno nei casi di malattia (o morte) provocata dall’esposizione all’amianto con la decisione della CEDU del febbraio 2025, osservando che la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo ha ribaltato i termini della questione e, pur concedendo agli Stati un margine di discrezionalità, ha stabilito il principio secondo il quale si deve tener conto, ai fini del conteggio dei dieci anni per la prescrizione, del momento in cui si manifesta la malattia causalmente legata all’esposizione all’amianto, fatto che può avvenire a distanza di molti anni. Pertanto, il termine di prescrizione dovrebbe iniziare a decorrere dal momento in cui la malattia si manifesta e non dal momento dell’ultima esposizione all’agente nocivo.
Riguardo, invece, al tempo necessario a prescrivere rispetto ai reati di lesione o di omicidio colposo per esposizione a sostanze nocive (come amianto) risulta determinante la corretta individuazione del tempus commissi delicti che, in ipotesi complesse, non è di facile individuazione.
Le difficoltà riguardano tutti quei casi in cui la condotta colposa posta in essere dall’agente abbia cagionato una malattia nel corpo o nella mente della vittima, la quale, però, muoia dopo un certo lasso di tempo.
In tale ipotesi il quesito è: il tempo in cui il reato è commesso coincide con la condotta colposa o con l’evento morte?
Sul punto, sono intervenute le Sezioni Unite (Cass. n. 40986/2018) che hanno portato alla conclusione che il tempus commissi delicti vada riferito al momento in cui la condotta è stata posta in essere.
Il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole e quello speculare del favor rei non possono che essere riferiti al momento in cui la condotta è posta in essere.
Infatti, se il principio di irretroattività funge da garanzia contro eventuali interpreti del legislatore e che l’art. 25 Cost. tutela come valore assoluto che non può essere bilanciato con altri valori costituzionale, il principio di retroattività della legge più favorevole si pone come corollario del principio di uguaglianza e del giusto processo di cui agli artt. 3 e 117 Cost.
Occorre precisare che la ragione dell’assolutezza del valore dell’irretroattività è racchiusa nella necessaria prevedibilità e valutabilità di ogni individuo delle conseguenze cui andrà in contro realizzando una determinata condotta e, dunque, nella sua capacità di autodeterminarsi.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte Suprema afferma: “E’ dunque la condotta il punto di riferimento temporale essenziale a garantire la “calcolabilità” delle conseguenze penali e, con essa, l’autodeterminazione della persona: ed è a tale punto di riferimento temporale che deve essere riconnessa l’operatività del principio di irretroattività ex art. 25 Cost., posto che “spostare in avanti” detta operatività, correlandola all’evento del reato, determinerebbe, qualora alla condotta interamente posta in essere nella vigenza di una legge penale sia sopravvenuta una normativa penale più sfavorevole, la sostanziale retroattività di quest’ultima rispetto al momento in cui è effettivamente possibile per la persona “calcolare” le conseguenze penali del proprio agire”. D’altronde, tale “calcolabilità” risulta essenziale per poter ritenere effettiva e rispettata la funzione rieducativa della pena di cui all’art. 27. Diversamente argomentando, infatti, il soggetto che accetti le conseguenze di una condotta e, successivamente al fatto, veda tali conseguenze mutate in pejus non potrà che vivere la condanna come un’ingiustizia e non di certo “rieducante”.
Già sol per questo, il tempus commissi delicti parrebbe dover coincidere con il momento in cui la condotta è posta in essere.
È chiaro che è solo nel momento in cui l’agente omette di compiere l’azione doverosa o pone in essere la condotta negligente che si pone in violazione del comportamento prescritto dalla norma penale.
Questa è l’ulteriore conferma che: “ai fini della successione di leggi penali, il tempo del commesso reato va individuato nella condotta, ossia nel momento rispetto al quale la funzione di prevenzione generale della norma penale può in concreto esplicarsi” (Cass. SS.UU., n. 40986/2018).
Ed appunto, le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “In tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale più favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale più sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta”.
Quanto su detto, tuttavia, vale solo con riferimento alla corretta individuazione della legge penale da applicare al caso concreto, motivo per il quale bisogna fare riferimento alla condotta colposa posta in essere dal datore di lavoro, che ha avuto efficienza causale rispetto all’evento malattia, prima, ed eventualmente morte, dopo, che non può che arrestarsi all’ultimo giorno di lavoro di ogni singolo lavoratore.
In ragione di ciò, se la legge applicabile all’epoca dei fatti è la più favorevole al reo sarà quella ad essere applicata.