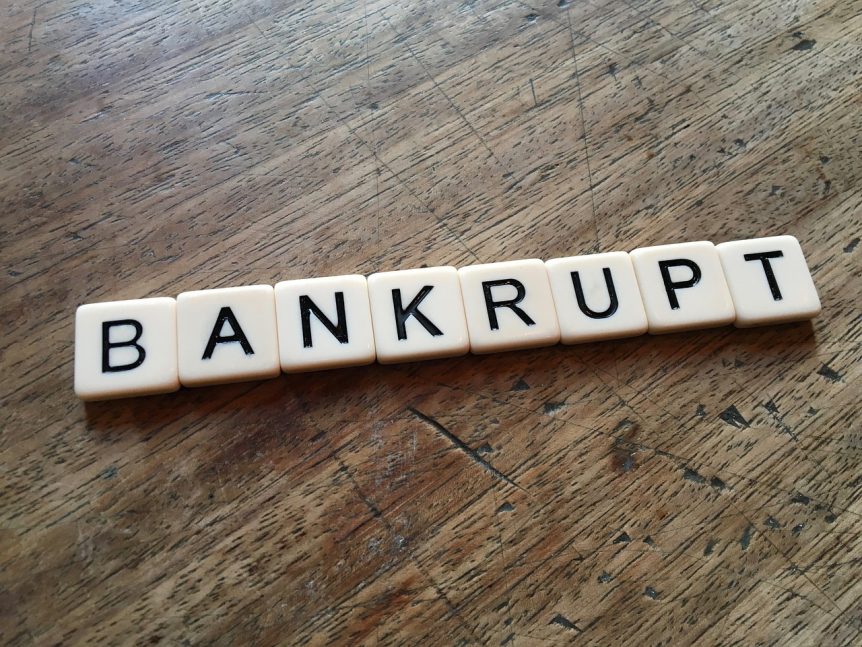a cura dell’avv. Maria Antonella Mascaro
Si porta all’attenzione una pronuncia della Corte di Cassazione sulla impossibilità di contestare, in alcuni casi, il reato di autoriciclaggio e quello di bancarotta fraudolenta.
Una particolare attenzione deve essere posta alla struttura stessa della fattispecie di autoriciclaggio, reato per il quale la condotta illecita deve essere temporalmente collocata dopola commissione del reato presupposto.
Ci sono, dunque, due momenti: quello di commissione del primo reato, cosiddetto reato presupposto, che ha generato i beni, il denaro o le altre utilità e quello in cui questi ultimi vengono impiegati, sostituiti o trasferiti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.
E’ fuor di dubbio che in tema di autoriciclaggio, il perfezionamento del delitto presupposto debba precedere il momento consumativo del reato di cui all’art. 648 ter c.p., giustappunto il delitto di autoriciclaggio.
Il caso
Il caso riguarda la contestazione di plurime condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale da reato societario, imputate al legale rappresentante e presidente del C.d.a. di una S.p.A. Il tribunale del riesame territoriale aveva ritenuto di annullare l’ordinanza genetica di applicazione della misura cautelare, limitatamente ai delitti di autoriciclaggio contestati, sottolineando che la condotta imputata all’indagato per l’autoriciclaggio, consistita nel trasferimento dei fondi dalla fallita alle società beneficiarie, coincidesse con la condotta distrattiva di cui pure era accusato.
Ricorre il Pubblico Ministero per vizio di motivazione sostenendo di aver fornito la dimostrazione, attraverso accertamenti bancari che il denaro sottratto alla società per azioni era confluito nell’alveo di altre tre società.
In sostanza il PM sostiene che lo spostamento del denaro dal conto della fallita a quello di altre società costituisca un fatto diverso dalla condotta di bancarotta, usato dall’indagato per mascherare l’effettiva provenienza del denaro grazie alla confusione con somme di provenienza lecita.
La decisione della Corte di Cassazione
Sul tema la Corte Suprema si è pronunciata più volte sviluppando un’interpretazione secondo la quale affinchè sia integrata la condotta di autoriciclaggio, distinta da quella di distrazione che configura la bancarotta fraudolenta per distrazione patrimoniale, è necessario un quid pluris, cioè un’attività ulteriore rispetto alla sottrazione della risorsa dell’impresa fallita, che eviti sovrapposizioni.
Nel caso che ci occupa non esiste la dimostrazione di un “prima” e di un “dopo”, in quanto la condotta è unica e realizza la fattispecie tipica della bancarotta e non dell’autoriciclaggio, poiché l’atto di distrarre e immettere in altre società determina la consumazione del solo reato di bancarotta per distrazione.